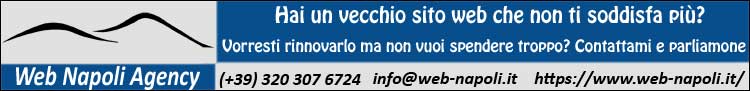Quanto costa davvero sbagliare una condanna. Partiamo da un dato secco: secondo la normativa attualmente in vigore, ogni giorno trascorso ingiustamente in carcere vale 235,82 euro. Un’indennità che suona quasi grottesca, se rapportata al prezzo umano della libertà perduta. Eppure è quella che il sistema giudiziario italiano prevede per i casi di ingiusta detenzione.
Nel caso di Alberto Stasi, recluso da oltre otto anni, parliamo di circa 2.920 giorni. Tradotto in termini monetari: più di 680.000 euro. Ma attenzione: si tratta solo della base. Perché in caso di revisione della sentenza e successiva assoluzione, il risarcimento può comprendere anche danni morali, biologici, professionali e d’immagine. In altri casi analoghi, e la giurisprudenza ce lo conferma, la cifra finale può tranquillamente essere quattro o cinque volte superiore a quella iniziale. Tradotto: lo Stato potrebbe arrivare a versare a Stasi una somma vicina ai tre milioni di euro.
Ma il conto non finisce qui. Perché nel frattempo, e questo è un fatto, Alberto Stasi ha già versato alla famiglia di Chiara Poggi circa 850.000 euro tra risarcimento e spese legali. Una cifra che, per uno che ha lavorato come centralinista nel carcere di Bollate per mille euro al mese, non è esattamente trascurabile. Dal 2023, ha ottenuto l’autorizzazione a lavorare all’esterno, come contabile, ma si presume che il suo stipendio attuale non superi di molto i duemila euro mensili. Eppure ha continuato a pagare, onorando l’impegno, anche a costo di indebitarsi.
Ora, se il processo venisse riaperto e Stasi assolto, cosa succederebbe a quella somma già versata? Potrebbe teoricamente chiederne la restituzione? La risposta, per quanto sorprendente, è sì. In linea teorica – e lo diciamo con tutte le cautele del caso – potrebbe aprirsi un nuovo contenzioso per recuperare quei soldi. Sarebbe un precedente raro, certo, ma non del tutto inedito nella storia della giurisprudenza italiana.
Facciamo due conti: tre milioni di euro di potenziale risarcimento per ingiusta detenzione, più 850.000 euro da recuperare (eventualmente) dalla famiglia Poggi, più spese legali, interessi e costi processuali per la revisione. Risultato? Il caso Stasi potrebbe costare allo Stato ben oltre quattro milioni di euro.
E questo in un Paese che, tra il 1992 e il 2022, ha speso più di 870 milioni di euro per errori giudiziari e detenzioni ingiuste. Una cifra che dovrebbe far riflettere, specie se consideriamo che spesso, come in questo caso, le vittime non sono solo quelle riconosciute in aula, ma anche quelle lasciate ai margini, in attesa di una verità che forse non arriverà mai.
Al netto delle responsabilità penali, che in questo momento non stiamo riesaminando, resta una questione: come gestisce lo Stato un potenziale errore giudiziario?
La verità è che il sistema delle revisioni processuali in Italia è un meccanismo complicato, spesso ostacolato da vincoli procedurali e da un atteggiamento di chiusura culturale. Eppure, quando ci sono elementi nuovi, non possiamo permetterci di ignorarli. Perché ogni errore che non correggiamo è una doppia condanna: per chi l’ha subito, e per la credibilità dell’intero apparato giudiziario.
Il caso Stasi, in fondo, non è solo il caso Stasi. È il paradigma di un sistema che, per quanto imperfetto, deve sapersi interrogare, correggere, evolvere. E deve anche saper pagare, quando sbaglia. Non si tratta di buonismo o garantismo a tutti i costi. Si tratta di responsabilità.
Quella che lo Stato deve assumersi non solo quando infligge una pena, ma anche, e forse soprattutto, quando quella pena si rivela infondata.
E ora? Forse Alberto Stasi è colpevole. Forse si, forse no. Questo lo stabilirà, o lo ristabilirà, un tribunale. Ma al di là della sentenza, la domanda resta: siamo davvero pronti a fare i conti – tutti – con gli effetti di un errore giudiziario? Con le sue conseguenze economiche, morali, civili?
Perché se la giustizia non è giusta, non solo tradisce chi subisce un’ingiustizia. Tradisce anche tutti noi.