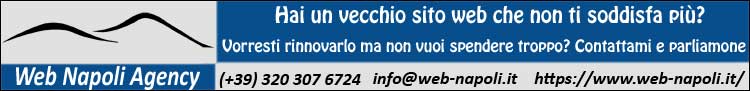Una riscoperta, tra memoria e resistenza, tornata a sgorgare lo scorso febbraio, l’acqua ferrata del Chiatamone sembrava perduta. E invece era lì, nascosta sotto strati di cemento, oblio e interessi. Ci sono voluti oltre quattro anni di studio, sopralluoghi e battaglie istituzionali per riattivarla. Il progetto, promosso da ABC (Acqua Bene Comune Napoli) e dai comitati civici – tra cui Hydrosòphia, Santa Maria di Portosalvo, il LAN (Laboratorio Architettura Nomade) e Mondo Scuola – è il risultato di un’alleanza virtuosa tra tecnica, cittadinanza attiva e tutela culturale. E questo, a mio avviso, è già un caso studio per chi si occupa di rigenerazione urbana e beni comuni.
Dal cuore della città, un’acqua dalla memoria lunga e, non un’acqua qualunque. La “suffregna” – chiamata anche “acqua ferrata” o “lucullana” – è un’acqua bicarbonato-alcalino-ferruginosa, tipica delle falde vulcaniche. Nasce a una temperatura costante di 21 gradi dalle viscere del Monte Echia, ed era celebre per le sue proprietà digestive e disintossicanti. Tanto che, fino agli anni ’60 del secolo scorso, era venduta direttamente nei chioschi della città, nelle caratteristiche “mummarelle”: anfore di terracotta porosa che la mantenevano fresca anche sotto il sole cocente.
Non era solo una bevanda. Era un gesto quotidiano, un rito urbano, un sapere popolare. Ed il fatto che, oggi, la sua fruizione sia prevista solo attraverso le mummarelle e non in bottiglie industriali, è più di un vezzo: è un’operazione culturale consapevole. L’oggetto diventa veicolo di senso, testimonianza materiale di un sistema ecologico ed economico che un tempo funzionava in equilibrio.
Con l’Unità d’Italia, la risorsa fu classificata ad “uso economico” e concessa ai privati. Gli alberghi di via Partenope ne fecero uso turistico – termale, mentre i cittadini furono allontanati dalla fonte. La pietra tombale arrivò nel 1973, durante un’estate segnata dalla psicosi da colera: la sorgente venne chiusa per motivi sanitari, l’accesso alla grotta interdetto e l’acqua dimenticata.
Ma qui la storia assume i contorni del paradosso: nel 1731, una lapide fatta scolpire da Carlo VI sul costone di Pizzofalcone garantiva la libera fruizione dell’acqua del Chiatamone a tutti i cittadini. Quel diritto, inciso nel marmo, fu disatteso nel silenzio generale. Oggi, quel monito ritorna d’attualità come documento politico oltre che storico.
La riattivazione della sorgente non è stata pensata come una semplice operazione di archeologia urbana. Il progetto “Hydrosphera”, coordinato da Alexander Valentino per il LAN, ha un obiettivo molto più ambizioso: fare del sito un bene comune vivo, gestito in co-progettazione tra cittadini, Comune e associazioni. Non una reliquia museale, quindi, ma un presidio civico che restituisca valore, educazione ambientale e bellezza al quartiere.
Parliamo di un bene pubblico a pieno titolo, da utilizzare – con le dovute garanzie igienico-sanitarie – anche come risorsa didattica, culturale e turistica. E se Napoli ambisce a candidare le sue acque storiche a Patrimonio Unesco, come auspicato dai promotori, questo tipo di gestione partecipata sarà una leva strategica.
La suffregna, nella sua umiltà minerale, è un’acqua che parla di noi, ci racconta chi siamo stati e chi potremmo tornare ad essere. Ci parla di un tempo in cui le risorse naturali erano vissute come patrimonio condiviso, non come opportunità di profitto. Un tempo in cui la cultura materiale – quella fatta di gesti, oggetti, saperi locali – era alla base di un modello di sostenibilità ante litteram.
E se oggi l’acqua torna a fluire, forse è il segnale che qualcosa sta cambiando. Che la memoria, se ben curata, può diventare leva di futuro. Che la città non è fatta solo di edilizia e piani regolatori, ma anche di fonti invisibili – fisiche e simboliche – che aspettano solo di essere rimesse in circolo.
La riattivazione della sorgente del Chiatamone è molto più di un fatto locale. Dimostra che, anche in contesti urbanizzati e frammentati, è possibile restituire senso e funzione a ciò che sembrava perduto. Dimostra che la partecipazione civica, se sostenuta da competenze e visione, può restituire risorse al territorio. Attesta che l’acqua – soprattutto quella di Napoli – non è solo un elemento, ma una narrazione.
E allora sì, possiamo dirlo: stavolta, Napoli è riuscita a farsi ascoltare non con le urla, ma con una voce sottile, sotterranea, limpida, proprio come un sorso d’acqua suffregna.